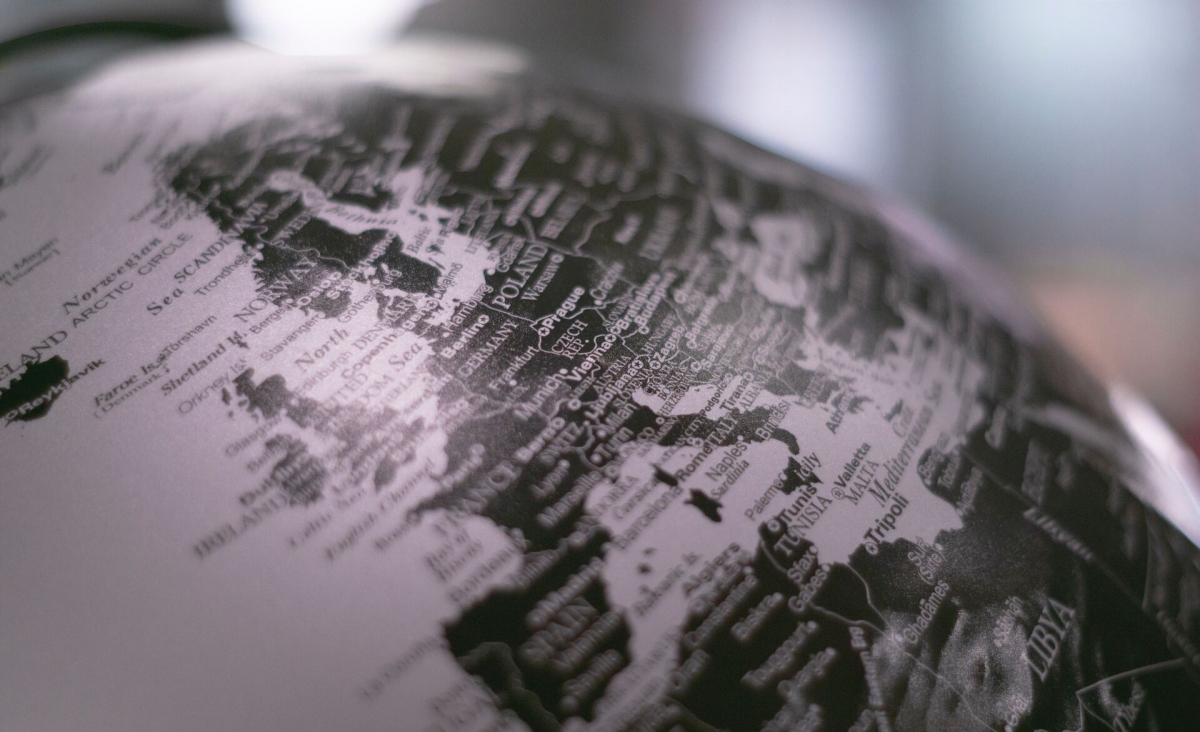18 dicembre: il trauma della migrazione
(dott.ssa Vittoria Castagner)
Il 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti. In questo articolo esploriamo il tema della salute mentale dei migranti, con particolare riferimento ai dati disponibili, alle tipologie di disturbi mentali associati alla migrazione e alle cause di tali disturbi nelle diverse fasi della migrazione.
Migrazione e salute mentale
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) stima che in riferimento ai dati relativi al 2020, ci siano circa 281 milioni di migranti internazionali nel mondo, ovvero il 3,6% della popolazione mondiale. Di questi, 26,4 milioni sono rifugiati; 4,1 milioni i richiedenti asilo.
A differenza dei migranti cosiddetti “volontari”, che lasciano il loro paese per un miglioramento della propria condizione socio-economica, i rifugiati sono migranti “forzati”: persone costrette ad abbandonare il proprio paese in quanto vittime di violenza – spesso correlata con la guerra – minacce, persecuzioni, deprivazioni, nonché vittime di carestie ed epidemie.
La costrizione alla migrazione e la frequente esposizione a gravi eventi traumatici, prima ma anche durante il viaggio migratorio, rendono questi soggetti particolarmente vulnerabili dal punto di vista psicologico.
I dati sulla salute mentale dei migranti
Le condizioni di salute mentale dei migranti che approdano sulle nostre coste non sono comunemente oggetto di valutazione.
Uno studio promosso dalla ONG Medici Senza Frontiere effettuato in Sicilia, e pubblicato nel 2017 (Crepet A. et al. 2017), sottolinea proprio questa carenza nel sistema di accoglienza, e riporta dei dati significativi e preoccupanti: tra i 385 migranti che hanno partecipato allo studio – la maggior parte giovani maschi dell'Africa occidentale che avevano lasciato i loro paesi d'origine più di un anno prima dell'arrivo –, il 50% ha ricevuto una diagnosi di disturbo della salute mentale. Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) è risultato essere la diagnosi più frequente (31%), seguita da quella di depressione (20%).
Le tre fasi del trauma migratorio
Lo studio evidenza che gli eventi traumatici avvengono sia nel paese d'origine sia durante la migrazione. Dati che trovano conferma in letteratura: rifugiati e migranti, e in particolar modo richiedenti asilo e migranti irregolari, possono infatti essere esposti a diverse esperienze traumatiche nel corso dell’intero processo migratorio.
In questo senso si può parlare di “trauma prolungato multidimensionale”, riferendosi proprio a quell’insieme di esperienze che costellano l’evento migratorio nelle sue diverse fasi.
Non solo il trauma pre-migratorio, ovvero quello vissuto nel contesto d’origine e che ne ha determinato l’abbandono, ma il trauma migratorio in senso proprio, legato alla fuga e al viaggio, è frequente ed è un forte fattore di rischio per lo sviluppo di PTSD e di altri disturbi mentali.
Tra gli eventi potenzialmente traumatici in questa fase è possibile includere la partenza forzata e improvvisa con frequente impossibilità di avvisare le persone care, la permanenza prolungata in campi profughi, i viaggi drammatici, la malnutrizione, l’essere soggetti a malattie non curate, ad aggressioni; essere testimoni della morte dei compagni di viaggio; vittime di sfruttamento e violenze, comprese quelle sessuali; la detenzione nei paesi di transito ed eventuali respingimenti.
La fase post-migratoria è però anche quella in cui i migranti forzati si vengono poi a trovare in un Paese che spesso non hanno scelto, in un contesto culturale molto diverso da quello di provenienza, e che richiede un cambiamento delle abitudini e degli stili di vita spesso all’insegna della precarietà: fattori di per sé traumatogeni.
In questo senso il contesto del paese d’accoglienza si presta a diventare un ulteriore trauma aggiuntivo: nello specifico, è acclarato come l’incertezza e l’insicurezza rispetto all’esito della richiesta di asilo, alla situazione abitativa e alle prospettive di impiego, oltre alla separazione dalla famiglia e alle aspettative per il futuro, impattino sulla salute a prescindere dalla presenza di precedenti traumatizzazioni.
Gli effetti del trauma migratorio
Vivere questo tipo di esperienze può portare allo sviluppo di quadri clinici psichiatrici anche molto gravi, ed è nella fase successiva, quella dell’accoglienza, che la vulnerabilità psicologica si manifesta più frequentemente.
Il quadro sintomatologico che si riscontra maggiormente è per l’appunto di natura post-traumatica: intrusioni diurne e notturne (ricordi/incubi angoscianti del trauma subìto) associate a conseguenti reazioni emotive e fisiche, disturbi del sonno, della memoria, dell’attenzione e della concentrazione, oltre a crisi d’ansia, disturbi depressivi, disturbi somatoformi.
Quando poi il trauma è frutto della violenza umana – come per esempio nei casi di tortura ormai ampiamente documentati – il danno psicologico risulta ancora più radicato: viene minata la fiducia di fondo che regola i rapporti umani, ovvero la possibilità stessa di fare riferimento agli altri, determinando un cambiamento durevole della stessa personalità.
Prendersi cura della salute mentale dei migranti
Nella sua complessità, l’esperienza della migrazione ha forti ripercussioni sulla vita e sulla salute delle persone; le sue implicazioni sono molteplici e necessitano pertanto di un’attenzione che non sia più esclusivamente medica, ma anche psicologica: soprattutto quando traumatica, è un’esperienza che espone al rischio di sviluppare psicopatologie invalidanti.
Valutare e riconoscere questo rischio è il primo passo per un’adeguata accoglienza, affinché il contesto di arrivo possa avere una funzione protettiva e di contenimento rispetto alla sofferenza emotiva di cui ogni migrante può essere portatore.
Bibliografia:
- ANCI et al. (a cura di), "Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati problemi aperti e strategie di intervento", Roma, 2010. (link)
- ANCI et al. (a cura di), Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015", Roma, 2015. (link)
- A. Crepet et al., "Mental health and trauma in asylum seekers landing in Sicily in 2015: a descriptive study of neglected invisible wounds", in “Conflict and Health” 10.1186/s13031-017-0103-3, 2017. (link)
- M. Danon e A. Miltenburg, "Rifugiati politici e salute mentale". Intervento Tratto Dagli Atti Della Conferenza Internazionale "Una Città Interculturale Da Inventare Esperienze Europee a Confronto", Comune di Padova e Università degli Studi di Padova, 2001. (link)
- International Organization for Migration (a cura di), "World Migration Report 2022", Ginevra, 2021. (link)
- World Health Organization (a cura di), "Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region: No public health without refugee and migrant health", Ginevra, 2018. (link)
Seguici sui social
Iscriviti alla nostra newsletter